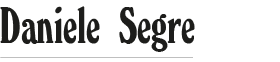Sara Caputo/Ha Keillah
È un caldo pomeriggio di inizio giugno: armata di registratore e taccuino, vado ad intervistare il regista cinematografico Daniele Segre, presso la sede della sua società di produzione, “I Cammelli”, a Torino. Un’occasione unica per parlare con qualcuno che lavora quotidianamente nell’affascinante mondo del cinema.
Il regista è un mestiere affascinante ma non molto diffuso: come ha cominciato la sua carriera lei?
Io non sono andato in nessuna scuola, né di cinema né di fotografia. Il mio lavoro è iniziato da una vera e propria passione per la macchina fotografica, che ho usato come strumento per documentare e raccontare Torino. Questo nei primi anni ’70.
Nel 1975 ho girato il primo film qui a Torino, sulla realtà delle tossicodipendenze, e da lì ho iniziato a usare non più solo la macchina fotografica, ma anche la cinepresa. Ma questo sempre partendo da una mia necessità, da un mio bisogno di esprimermi.
Lei si è sempre dedicato al “cinema utile”…
Ho fatto anche delle regie teatrali e dei film di finzione con attori, ma in generale sono più conosciuto come un regista della realtà, che si è occupato di raccontare storie e situazioni di persone che vivono in condizioni di grande e difficile marginalità.
Per lei dunque il cinema è solo uno strumento educativo, per documentare la realtà, o può essere anche intrattenimento puro?
Io penso che possa e debba essere anche intrattenimento, ma che debba fornire uno strumento culturale utile a costruire una consapevolezza della propria condizione, a superare limiti prodotti dall’ignoranza, dalla paura. Dirò un’ovvietà: il cinema è uno strumento potentissimo, come anche la televisione. Ma nei tempi in cui viviamo essa è usata per vilipendere la dignità delle persone e annullare la loro identità. Il servizio pubblico radiotelevisivo italiano ormai non ha più la dignità di esistere, per il tipo di prodotti che produce. Io credo che si debba lavorare per costruire un futuro adeguato nel rispetto delle persone, i giovani e non solo, che devono nutrirsi di cultura e poter esprimere la loro opinione.
“Cinema utile” non è quello in cui un regista esprime il proprio punto di vista e condiziona lo spettatore a pensare come vuole lui: è il cinema che ti pone delle questioni, dei dubbi, e ti aiuta a riflettere, per far emergere il tuo punto di vista, cosa che io considero un obiettivo primario per un’emancipazione e una maturazione di ogni singola persona. Occorre essere in grado di leggere immagini e racconti che ti vengono proposti, decodificare, analizzare e capire che tipo di offerta culturale ti viene fatta. A volte un “bel prodotto” può essere una trappola da un punto di vista ideologico. Non devi essere passivo, ma in grado di valutare, scegliere e determinare la tua consapevolezza rispetto al problema che quel film in particolare ti propone.
Lei ha in particolare dei modelli, degli ispiratori, tra i registi che l’hanno preceduta?
Il mio lavoro, come le ho precisato, parte da un bisogno reale di esprimermi. Non sono andato a scuola di cinema, non sono un estremo cinefilo che vive di riflesso. Sicuramente gli autori che mi hanno stimolato nella mia ricerca sono Rossellini e Cesare Zavattini per quanto riguarda il cinema della realtà, e per quanto riguarda il cinema di finzione la scuola tedesca, da Wenders a Fassbinder ad altri. La mia espressione viaggia su questo confine, tra finto e vero, tra il teatro e il cinema.
Guardando la sua filmografia, ho visto che molti dei suoi film sono opere biografiche… Per esempio quei due lavori su Frank Sinatra e Liza Minnelli del 1987…
Sì, li ho seguiti entrambi nelle loro tournée italiane, ma quello in realtà era un lavoro su commissione per conto di Raiuno. Ne ho fatti invece altri, in maniera indipendente, e ultimamente ho ripreso questo filone, con una serie di ritratti di personaggi legati alla cultura italiana. Recentemente ho girato – ed è ancora inedito, sarà presentato a breve – un lavoro sulla fotografa Lisetta Carmi, una signora di ottantasei anni, anche lei di famiglia ebraica, che a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 ha scattato alcune fotografie straordinarie e si è fatta conoscere in particolare per fotografie nel mondo dei travestiti, scattate a Genova e all’estero, anche in Israele. Ho fatto anche un ritratto dell’editore Luciano Lischi, della casa editrice Nistri Lischi. E poi ho appena terminato le riprese del ritratto del decano dei critici cinematografici, Morando Morandini, che non ho ancora iniziato a montare, e monterò nelle prossime settimane.
Ha trattato anche spesso temi di attinenza ebraica… Qual è il rapporto tra il suo essere ebreo e il suo cinema?
Come dicevo, la mia ricerca è nata da un bisogno mio personale di raccontare la realtà nella quale vivevo. Poi, nel corso del mio lavoro, mi è capitato, sempre per mia scelta, di affrontare anche il tema ebraico, a partire dal lungometraggio Manila Paloma Blanca (1992). Nel 1999 ho girato il documentario Sinagoghe, ebrei del Piemonte. E poi ho anche fatto alcuni audiovisivi sulla sinagoga di Torino, “Ebrei a Torino”, con diapositive e fotografie. Diciamo che l’interesse c’è sempre stato e c’è ancora, però per vari motivi ho punteggiato il mio lavoro solo con queste opere che le ho appena citato.
Gli argomenti trattati nei suoi lavori sono molto varî: di solito che cos’è che le fornisce le idee, gli spunti?
Mah, non c’è una ricetta che io segua ogni volta: a volte è l’istinto, a volte l’urgenza sociale, a volte l’indignazione… Non so, le faccio un esempio: uno degli ultimi film che ho fatto, che ha avuto una grande eco a livello nazionale, tratta degli incidenti nel mondo del lavoro. Morire di lavoro è il titolo. Io l’ho fatto un anno prima della tragedia della Thyssen Krupp, non ho cavalcato la moda mediatica che si è innescata al momento. Stimolo è stata la mia indignazione come cittadino e poi come regista di fronte a questi veri e propri bollettini di guerra che arrivano dai luoghi di lavoro, dove ogni giorno muoiono tra le tre e le quattro persone. Questo è stato uno degli elementi che mi hanno spinto a realizzare questo film, senza che nessuno me lo chiedesse. In effetti ha avuto dei problemi, e lo stesso servizio pubblico, la Rai, non ha voluto mandarlo in onda, una cosa letteralmente scandalosa: il film è stato presentato alla Camera dei Deputati a Roma e al Parlamento Europeo di Strasburgo, ha avuto una grande eco e grandi riscontri dal punto di vista dei contenuti e della qualità. Non è un film didascalico, ideologico, di parte, ma un film che ha per protagonisti parenti delle persone che sono morte e lavoratori che quotidianamente rischiano la vita nei cantieri dell’edilizia, e che purtroppo non hanno nessun genere di diritto di parola, non contano niente. E personalmente non sono d’accordo, quindi ho cercato di dare il mio contributo per far conoscere la questione.
Un altro lavoro che ho fatto, sugli incidenti del sabato sera, è invece nato da un’idea che ho avuto in macchina, un lunedì, sentendo al giornale radio il bilancio di quel fine settimana: erano morti trentatre giovani, il che è una bestemmia, ma è una cosa che capita spesso. E allora mi son detto “bisogna fare qualcosa”, e ho fatto un film, dal titolo Sei minuti all’alba.
Insomma, è una questione di vivere il proprio presente e saperlo interpretare, e se necessario intervenire. Non dico che posso farlo, ma mi impegno al massimo per dare il mio contributo. Magari mi può succedere che cinque minuti prima non ci penso neanche, e cinque minuti dopo ho già deciso, in piena libertà. È un’azione di comunicazione, di utilità pubblica, con finalità di educazione, tesa a dare uno strumento di riflessione al pubblico. Poi devo fare i conti anche con la fattibilità economica del progetto…
Lei ha coraggiosamente scelto la strada della regia e della produzione indipendente: qual è la situazione di questo settore in Italia?
Resistere. La situazione è assolutamente drammatica, di una durezza inaudita. Non c’è grande visibilità. Tutto quello che le ho detto sono belle parole, e le confermo, ma devi avere una convinzione e una determinazione tali che ti permettano di resistere un giorno in più, di fronte ai problemi che emergono sempre di più nel settore della comunicazione in Italia. Se lei mi fa la domanda “ma lei come ce l’ha fatta?” non so risponderle. È tutto determinato dalla mia volontà e dalla mia capacità di insistere e lottare per potermi esprimere, come farebbe qualunque artista: una vera e propria resistenza culturale.
Nel 1981 ho fondato “I Cammelli”, la mia società di produzione, con cui mantengo in piedi la mia ricerca e la mia libertà di espressione. Faccio quello che posso, ma in piena libertà, senza dipendere da nessuno. Ci sono problemi di collocazione e visione sul mercato dei miei lavori, ma ho la titolarità di scegliere e fare quello che voglio.
Ma i suoi lavori che tipo di distribuzione hanno? Nelle sale non mi pare siano mai comparsi…
Nelle sale qualcuno è andato. Altrimenti una distribuzione alternativa curata direttamente dalla mia società, i DVD dei miei film si possono trovare in vendita sul mio sito www.danielesegre.it, e in alcune librerie di Torino, di Roma e di Pisa che stanno cominciando a venderli.
Comunque alcuni dei suoi film hanno avuto notevole successo internazionale, riconoscimenti, premi…
Sì, prossimamente anche il lavoro di Lisetta Carmi avrà una visibilità importante. Sicuramente il mio lavoro è molto apprezzato, e ne è riconosciuta anche la qualità. Sono palcoscenici importanti, utili, ma non fondamentali per mandare avanti un processo produttivo: ci sono dei costi, non basta solo la gloria. Alcuni lavori hanno vinto anche festival internazionali, le biblioteche francesi hanno adottato moltissimi miei film: quando faccio un film me lo chiedono e lo mettono nel circuito delle biblioteche pubbliche. La cosa ovviamente è molto gratificante.
E al momento in quali progetti è impegnato?
Quest’anno in modo particolare l’ho dedicato all’insegnamento: da sedici anni insegno alla Scuola Nazionale di Cinema, il Centro Sperimentale di Cinematografia, col mio corso che si chiama “Cinema e realtà”. Adesso a giugno inizio un corso in Toscana, a Cascina (PI), per esperto di video documentazione sociale, che andrà avanti fino a dicembre, ma si interromperà a luglio per riprendere a settembre. E nel buco, da fine luglio ai primi di agosto, faccio un corso a Bobbio, in provincia di Piacenza, all’interno dell’esperienza del festival voluto e diretto da Marco Bellocchio, sempre per far apprendere ai giovani il linguaggio del cinema della realtà.
In più ho fatto il Lisetta Carmi, che dev’essere ancora presentato, e il film su Luciano Lischi, e monterò nei ritagli di tempo il film su Morando Morandini. Altre idee le avrei, ma purtroppo le giornate sono solo di ventiquattr’ore… Comunque un aspetto su cui sto riflettendo molto è che il mio lavoro mi sta portando sempre più lontano da Torino.
Dal punto di vista cinematografico mi è sembrato che negli ultimi tempi Torino si stia un po’ risollevando, stia quasi ritornando ai vecchi fasti, come cent’anni fa…
Un po’ sì, ma dipende anche da quello che fai, e da dove lo trovi da fare. A Torino per motivi anche di opportunità economica vengono molte produzioni da fuori a girare dei film che sono stati pensati e ideati da un’altra parte. Riescono a trovare le location, l’ospitalità, permessi di ripresa e occupazione del suolo pubblico economicamente convenienti, il che è una cosa meritoria per Torino. Per Morire di lavoro ho girato in quattro regioni, e anche a Torino, dove ho avuto il sostegno del Piemonte Doc Found: sono molto attenti e sensibili ai progetti interessanti.
Lei parlava prima del poco tempo e dei tanti progetti: quanto tempo impiega, in media, a portare a termine un lavoro?
La mia è una struttura di produzione indipendente, che combatte quotidianamente e non dispone di tantissime risorse: bisogna ottimizzare al meglio ciò che si ha, per vincere la propria scommessa culturale. Tutto è in proporzione alle possibilità che si hanno. Ogni progetto ha la sua storia, e dall’ideazione alla realizzazione possono passare anche dieci anni, oppure pochissimo tempo. Nel 2002 ho fatto un lungometraggio, Vecchie, con due straordinarie attrici, Barbara Valmorin e Maria Grazia Grassini: l’idea mi è venuta per caso una sera a Roma e un mese dopo il film era già stato girato. E dopo sei mesi è diventato uno spettacolo teatrale. È stato al Festival di Venezia, in Francia ha vinto il Premio CICAE, e le attrici hanno avuto il premio come migliori interpreti femminili al Festival del Cinema Italiano di Annecy . Questo è un esempio estremo, ovviamente, perché normalmente queste cose è difficile che capitino. Però è chiaro che nelle condizioni di una piccola società di produzione non si può voler fare il passo più lungo della gamba, bisogna navigare a vista e non spendere più soldi di quelli che hai. E visto che ce n’è pochissimi, bisogna spendere poco e girare il numero di giorni giusti, per evitare di non avere poi più le risorse e mettere in crisi l’intero progetto artistico. A me non interessa fare il film della mia vita, ma mandare avanti il mio progetto di ricerca, che è fatto da tanti film. Ipotecare tutto quello che hai per fare un film è pura follia: ci sono persone che l’hanno fatto, ma è sconsigliabile, entri in un girone d’inferno. L’aspetto bello lo conoscono tutti, ma quello meno bello, problematico, è che per fare queste cose serve una quantità di risorse più o meno elevata. Se perdi di vista il tuo rapporto con la realtà… Costa tutto, e costa tanto.
In una situazione di produzione indipendente devi avere anche la capacità di arrangiarti, trovare delle soluzioni che non siano inferiori dal punto di vista della qualità, magari artisticamente innovative, ma che contengano i costi. Devi avere un grande spirito artigianale. A volte addirittura lavori meglio se hai pochi soldi: sei assolutamente concentrato, e trovi delle soluzioni che dal punto di vista del linguaggio sono innovative, quindi non sviliscono l’opera, ma anzi l’arricchiscono. È un limite che può dare all’opera un valore aggiunto straordinario. Se invece perdi il senso della misura è veramente pericoloso: se sfori, sfori di tantissimo. E poi hai l’incubo di dover recuperare i soldi: non puoi cambiare nazione e sparire, insomma. Ci sono persone che l’hanno fatto, ma non è il mio caso, ci mancherebbe altro. Devi ragionare come il bravo padre di famiglia: hai la responsabilità di far nascere un nuovo figlio, un film, ma anche di non tradire la fiducia delle persone che lavorano con te, non pagandole. E quindi devo stare attento di volta in volta e valutare, a partire dall’idea che mi viene. L’altro elemento che potrebbe essere assolutamente demoralizzante è iniziare un’avventura e lasciarla a metà.
Dev’essere dura. Però credo che il suo sia uno dei mestieri più belli che esistano…
È una sfida vera e propria, però è una sfida appassionante. Io mi sento fortunato e privilegiato, per poter fare innanzitutto un lavoro che mi piace, anche se è faticoso e difficile per quanto riguarda la visibilità. Ogni giorno quando mi sveglio penso a questa fortuna che mi sono costruito, che però non è eterna, come non lo sono i diritti. Come cittadini dobbiamo ricordarci che i nostri diritti non sono cose eterne, da un giorno all’altro possono sparire, come la libertà di stampa, per esempio, quello che sta succedendo in questi giorni in Italia. Li devi ribadire giorno per giorno. E lo stesso questa possibilità di esprimermi, fare il cinema che voglio, è un grande privilegio ma devo ricordarmi che non è una condizione eterna. Non è che al momento in cui sono nato il rabbino mi ha dato questo lasciapassare per l’eternità come artista! È una cosa che mi devo conquistare, e non sempre facile, specie se affronti degli argomenti che possono essere interpretati in un modo sbagliato e dare fastidio. E poi rischi continuamente di essere travolto da problemi più grandi di te, che sono quelli economici. L’importante è ricordarselo.
Io ho scelto la strada dell’indipendenza proprio per non cadere vittima di una subalternità inquietante, che avrebbe ridotto ai minimi termini la mia potenzialità. Se lei vede la mia filmografia, vede quante cose ho fatto, ma le ho fatte perché ero nella piena libertà di decidere che cosa fare; altrimenti avrei fatto l’un per cento di tutto questo.
Insomma, il bilancio della sua carriera è positivo…
Se mi chiede “ma lei è felice?” le posso dire che felice magari no, “felice” sono solo degli attimi, come può essere una persona normale. Però sono orgoglioso e soddisfatto di me stesso rispetto all’impegno che ho profuso, e tranquillo con la mia coscienza: ho sempre fatto quello che volevo. Ma non lo dico con superbia, perché questa libertà ha un prezzo altissimo, nessuno me l’ha regalata. È anche espressione di diversità: già sono ebreo, e da quando sono nato questa diversità me la sono portata addosso. In più, grazie anche ai miei genitori e alla mia educazione ebraica mi sono sempre formato rispetto al mio libero arbitrio, nella piena facoltà di decidere, anche sbagliando, cosa era meglio per me. È importante, molto complicata e ha un prezzo alto.